I contribuenti in regime forfettario che decidono di riscattare la laurea possono ottenere le detrazioni fiscali e le deduzioni? Ecco cosa dicono le norme.

I costi sostenuti per il riscatto della laurea possono essere portati in detrazione o deduzione dai contribuenti in regime forfettario?
Il riscatto della laurea consente di avere il riconoscimento a fini pensionistici dei contributi per la durata legale del corso di laurea. Si tratta di una scelta da ponderare con attenzione e consigliata nel caso in cui manchino degli anni di contributi per avere accesso alla pensione.
La valutazione deve essere ponderata perché il riscatto della laurea ha un costo piuttosto elevato, questo può essere mitigato attraverso le agevolazioni fiscali. In base al soggetto che paga il riscatto della laurea ci possono essere deduzioni o detrazioni fiscali.
Brutta sorpresa però per chi è in regime forfettario e opta per il riscatto della laurea. Ecco perché.
Riscatto della laurea, le agevolazioni fiscali
La normativa prevede che i contributi volontari versati per il riscatto della laurea possono essere portati in deduzione dal reddito fino a concorrenza dello stesso dal contribuente che li ha versati.
Se i contributi sono versati in favore di inoccupati da familiari a cui sono fiscalmente a carico (ad esempio il genitore versa i contributi per il riscatto della laurea del figlio inoccupato) è possibile ottenere la detrazione al 19%.
Ma cosa succede se il contribuente che paga i contributi per il riscatto della laurea è un titolare di partita IVA in regime forfettario?
leggi anche
Detrazioni Irpef 730/2025, elenco dei tagli
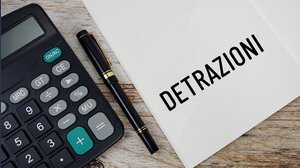
I contribuenti in regime forfettario perdono detrazioni e deduzioni per il riscatto della laurea
Le norme del regime forfettario sono abbastanza rigide. Chi aderisce al regime forfettario non beneficia della deduzione analitica delle spese sostenute, ma di una deduzione forfettaria determinata in base al coefficiente di redditività.
In poche parole chi aderisce al forfettario non paga le imposte sull’intero ammontare di compensi e ricavi ma su una quota determinata in base alla tipologia di attività.
Il coefficiente di redditività è determinato tenendo in considerazione i costi medi sostenuti da titolari di partita IVA in regime ordinario con attività uguali. Ad esempio per il commercio all’ingrosso e al dettaglio il coefficiente di redditività è al 40%, quindi i forfettari pagano l’imposta sostitutiva sul 40% dei ricavi. Nella maggior parte dei casi il coefficiente è fissato al 67%.
La deduzione analitica delle spese non è l’unica caratteristica del forfettario, infatti, c’è anche un’aliquota al 15% che scende al 5% nei primi 5 anni di attività. Considerando che l’Irpef a scaglioni prevede un’aliquota minima del 23% c’è comunque un vantaggio economico, aumentato dal fatto che l’imposta sostitutiva sul reddito non prevede l’applicazione di addizionali.
A fronte della deduzione forfettaria delle spese, la normativa prevede un unico caso di deduzione analitica delle spese dal reddito: i contributi previdenziali obbligatori.
Non si può interpretare estensivamente la norma fino a comprendere la deduzione analitica anche dei contributi per il riscatto della laurea, questi, infatti, sono contributi volontari/facoltativi e non obbligatori. Ne consegue che i forfettari non possono ottenere agevolazioni fiscali per il riscatto della laurea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA






