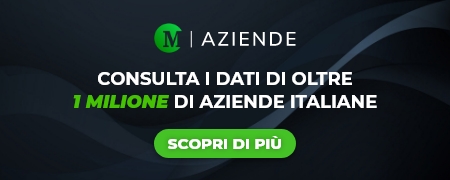Perché un’azienda vale più dei suoi beni? La risposta è l’avviamento aziendale, il capitale invisibile che decide il vero prezzo.

Se un’impresa è ceduta o conferita, il prezzo pagato non corrisponde quasi mai al solo valore dei beni materiali. C’è sempre un di più che riflette la clientela fidelizzata, la reputazione costruita nel tempo, l’organizzazione interna e la capacità di produrre reddito superiore alla media del settore. In economia questo valore è definito avviamento aziendale e costituisce un bene immateriale che misura la forza competitiva e la capacità di continuità dell’impresa.
Che cos’è l’avviamento aziendale e perché è centrale per un’impresa
Sul piano giuridico, l’art. 2426, n. 6 del codice civile, stabilisce che:
“L’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo sostenuto, ed è ammortizzato entro un periodo di tempo limitato, comunque non superiore a dieci anni.”
Ne discende che l’avviamento non è una voce discrezionale, può comparire in bilancio solo se realmente acquistato, mai se generato internamente dall’imprenditore.
È importante non confondere l’avviamento aziendale con "l’indennità per perdita di avviamento commerciale” prevista dall’art. 34 della l. n. 392/1978. Quest’ultima riguarda le locazioni ad uso commerciale e attribuisce al conduttore uscente, salvo particolari eccezioni, un diritto a un’indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone, elevate a 21 in caso di attività alberghiere. Si tratta quindi di un istituto completamente diverso, legato al rapporto locatizio e non alla valorizzazione contabile dell’impresa.
Quali sono i tipi di avviamento aziendale?
L’avviamento non è una categoria unica, ma assume forme diverse a seconda dei fattori che lo determinano.
Avviamento oggettivo e soggettivo
Si parla di avviamento oggettivo quando il plusvalore deriva da elementi esterni all’imprenditore, come la posizione geografica di un negozio in una via ad alta affluenza o l’inserimento in un mercato in crescita. Un bar situato in una stazione ferroviaria avrà un avviamento oggettivo superiore a quello di un esercizio identico ma in una zona periferica, proprio perché la clientela potenziale è molto più ampia.
Diverso è l’avviamento soggettivo, legato alle capacità organizzative, gestionali o creative dell’imprenditore. In questo caso il valore è connesso alla persona che guida l’attività: pensiamo a un ristorante che prospera grazie alla notorietà dello chef o a uno studio professionale che deve la propria redditività alla reputazione del fondatore. Proprio perché dipendente da fattori personali, l’avviamento soggettivo è meno trasferibile e più difficile da stimare.
Avviamento positivo e negativo
Quando il prezzo pagato per l’acquisizione di un’azienda eccede il valore del patrimonio netto rettificato, si parla di avviamento positivo. È il caso, ad esempio, di una società che, pur possedendo beni materiali di valore limitato, riesce a generare profitti elevati e costanti: l’acquirente sarà disposto a pagare di più per acquisire tale capacità di reddito.
All’opposto, esiste anche l’avviamento negativo, noto come badwill , che si verifica quando il prezzo d’acquisto è inferiore al patrimonio netto contabile. Ciò accade spesso in presenza di situazioni di crisi, passività potenziali o difficoltà operative che spingono il venditore ad accettare un corrispettivo ridotto.
Come si calcola l’avviamento aziendale: metodi e formule con esempi
Determinare l’avviamento significa quantificare quel valore immateriale che un’impresa porta con sé oltre al patrimonio netto.
Il metodo più diffuso è quello reddituale, che parte dal sovrareddito, cioè dalla differenza tra il reddito medio dell’impresa e il reddito medio normale che un operatore similare otterrebbe con gli stessi capitali investiti.
“La formula è semplice: avviamento = sovrareddito × numero di anni.”
Se un bar produce un utile medio di 100.000 euro, mentre la redditività normale del settore sarebbe di 60.000, il sovrareddito è pari a 40.000. Moltiplicandolo per cinque anni, periodo usualmente considerato congruo, si ottiene un avviamento di 200.000 euro.
Invece, il metodo patrimoniale confronta il prezzo pagato per l’acquisizione con il patrimonio netto rettificato della società. Se una società industriale viene venduta a 10 milioni di euro e il suo patrimonio netto, dopo rettifiche e rivalutazioni, è pari a 9,5 milioni, l’avviamento sarà pari a 500.000 euro. In questo caso, il valore riflette la disponibilità dell’acquirente a pagare un sovrapprezzo rispetto ai beni materiali e finanziari iscritti a bilancio.
Vi è poi il metodo misto, che combina elementi dei due precedenti: considera sia la capacità dell’impresa di produrre sovraredditi, sia il differenziale rispetto al valore patrimoniale. È spesso utilizzato nelle operazioni straordinarie più complesse, dove occorre dare un peso equilibrato a entrambi i profili.
Norme e regole di bilancio: dal codice civile agli standard internazionali
L’avviamento non è un valore naturale, non esiste “in sé”, esiste così come il legislatore e i principi contabili decidono di rappresentarlo.
Il codice civile stabilisce che l’avviamento si iscrive solo se è stato acquistato a titolo oneroso, mai se è generato internamente. E una volta iscritto, deve essere ammortizzato entro un periodo definito, comunque non superiore a 10 anni. Non solo, la società è tenuta a spiegare in Nota integrativa i criteri adottati, perché il lettore del bilancio capisca come è stato calcolato e in che misura resterà a gravare sui conti futuri.
Il principio contabile OIC 24 sviluppa questo approccio, vieta di contabilizzare il goodwill “interno” e impone che la vita utile sia stimata su basi oggettive. Solo quando la stima non è attendibile si applica la regola di fallback dei dieci anni. In pratica, l’avviamento non è un valore libero, ma un costo da ripartire gradualmente, con un orizzonte temporale preciso e verificabile.
Invece, sul fronte internazionale, l’IFRS 3 e lo IAS 36 non prevedono ammortamenti fissi: l’avviamento resta in bilancio senza limiti temporali e ogni anno deve superare un impairment test. Se il valore non è più recuperabile, scatta la svalutazione. Non c’è gradualità, ma un meccanismo binario o l’avviamento resta invariato, o viene ridotto anche in misura drastica.
Con l’OIC domina la prudenza, che distribuisce il costo in modo certo e programmato. Con gli IFRS prevale l’idea di rappresentare il valore “reale” dell’impresa, anche al prezzo di rendere il bilancio più volatile e di esporlo a svalutazioni improvvise.
Per le PMI italiane significa stabilità e previsioni affidabili; per le società quotate significa maggiore aderenza al mercato ma anche costi di valutazione più elevati e rischi di oscillazioni improvvise. La stessa impresa, a seconda dello standard applicato, può mostrare in bilancio un avviamento che si dissolve in dieci anni oppure che resta invariato fino al giorno in cui, improvvisamente, viene svalutato.
Costi e fisco: quanto incide l’avviamento in azienda
L’avviamento non è solo una voce tecnica di bilancio, comporta conseguenze economiche e fiscali. Il primo elemento da considerare sono i costi diretti: la quota di prezzo corrisposta per l’acquisto di un’azienda o di un suo ramo che eccede il valore del patrimonio netto e che viene contabilizzata come goodwill. È il sovrapprezzo che l’acquirente paga per assicurarsi la clientela, il marchio, la reputazione o la posizione sul mercato.
Accanto a questi vi sono i costi indiretti, essenziali per arrivare a una corretta valutazione. Si tratta delle parcelle per consulenti legali e fiscali, delle perizie di stima necessarie a determinare il valore effettivo dell’azienda, delle spese per la due diligence e degli oneri notarili e amministrativi legati all’operazione. Tutti elementi che incidono sul costo complessivo e che devono essere messi in conto sin dalla fase preliminare.
Ammortamento fiscale dell’avviamento: perché dura 18 anni
Sul versante fiscale, la norma di riferimento è l’art. 103 del TUIR, secondo cui:
“L’avviamento è deducibile ai fini delle imposte dirette in quote costanti non superiori a un diciottesimo del valore per ciascun esercizio.”
Significa che, indipendentemente dall’ammortamento contabile, il legislatore fiscale impone un periodo di deduzione pari a 18 anni, più lungo rispetto al limite massimo di 10 previsto dal codice civile e dall’OIC 24. Quindi, mentre nel bilancio la società può ammortizzare il goodwill in un arco temporale non superiore ai 10 anni, sul piano tributario la deduzione è più lenta e diluita in 18 esercizi.
Gli esempi concreti aiutano a comprendere meglio. Nel caso dell’acquisto di un bar in centro, il prezzo di cessione può risultare molto più alto rispetto al valore contabile degli arredi e delle attrezzature: l’avviamento è legato quasi interamente alla posizione e alla clientela abituale. In bilancio verrà ammortizzato in un periodo massimo di dieci anni, mentre ai fini fiscali la deduzione avverrà in diciotto anni, con un impatto differito sul reddito imponibile.
Diverso è il caso di una fusione industriale che generi un avviamento negativo, il cosiddetto badwill. Qui l’acquirente paga un prezzo inferiore al patrimonio netto rettificato e il differenziale viene contabilizzato come componente negativa che riduce il valore complessivo dell’operazione. Dal punto di vista fiscale, il badwill non genera deducibilità automatica, ma ha riflessi sulla base imponibile e può comportare un diverso trattamento delle plusvalenze o minusvalenze future.
© RIPRODUZIONE RISERVATA