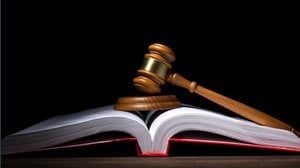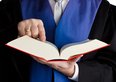Approvato in CdM il DDL riforma forense 2025: parere di congruità esecutivo, equo compenso solidale, soci 2/3 e reti tra studi. Tutte le novità per avvocati e praticanti.

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso settembre segna la più ampia revisione dell’ordinamento forense dalla l. n. 247 del 2012. L’obiettivo è aggiornare la professione alle nuove forme di esercizio e alle regole del mercato legale, mantenendo intatta la natura pubblicistica della funzione difensiva. Il DDL introduce anche un sistema nazionale per il praticantato digitale e stabilisce criteri uniformi per l’accesso e le specializzazioni, coordinati dal CNF.
Cosa prevede il DDL riforma ordinamento forense 2025?
Nel comunicato n. 140 del Governo si legge che la riforma:
“Intende riaffermare i principi fondamentali di indipendenza, libertà e autonomia dell’avvocato, adeguando l’ordinamento forense alle evoluzioni sociali ed economiche della professione.”
Tra i principi risaltano alcuni ritorni simbolici e giuridici. Viene ripristinato il giuramento dinanzi al Consiglio dell’Ordine come atto solenne di ingresso nella professione; si rafforza il segreto professionale, esteso anche alle attività di consulenza continuativa; è inoltre ribadito l’obbligo di polizza RC professionale con massimali minimi stabiliti e aggiornabili periodicamente dal Ministero della Giustizia; si riafferma la personalità dell’incarico, in modo che ogni mandato resti strettamente riferibile all’avvocato che lo accetta, anche se svolto in forma associata o societaria.
Un altro pilastro della riforma riguarda il Consiglio Nazionale Forense, che torna al centro del sistema. Il CNF è garante unico dell’elaborazione e dell’aggiornamento del codice deontologico, con il potere di definire regole uniformi sulla formazione continua e sull’accesso alle specializzazioni. È una scelta che punta a ridurre la frammentazione interpretativa e a dare maggiore certezza disciplinare agli Ordini locali.
Quando entra in vigore la riforma forense?
Il disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense è attualmente in fase di discussione parlamentare. Dopo il via libera del Governo, il testo è stato trasmesso alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, che stanno procedendo all’esame articolo per articolo. Trattandosi di legge- delega, il Governo avrà 6 mesi dall’entrata in vigore per adottare i decreti legislativi attuativi e ulteriori 12 mesi per eventuali disposizioni integrative o correttive.
L’obiettivo politico dichiarato dal Ministero della Giustizia è approvare il provvedimento entro la fine dell’anno, in modo da consentire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro i primi mesi del 2026.
Come cambiano le società tra avvocati, soci non professionisti e reti forensi?
La riforma forense 2025 tocca uno dei nodi più sensibili della professione: le società tra avvocati (STA) e le forme organizzate di esercizio dell’attività legale.
Nelle società tra avvocati, almeno i due terzi del capitale, dei diritti di voto e degli utili devono spettare a professionisti iscritti all’albo. La norma, che modifica l’art. 4 del D.lgs. n. 96/2001 e coordina la l. n. 247/2012:
“Punta a evitare l’ingresso di soci di puro capitale in posizione di controllo e a preservare la natura professionale dell’impresa forense.”
Significa che chi non è avvocato potrà restare socio solo in misura minoritaria, e non potrà incidere sulle scelte gestionali o sul contenuto delle prestazioni legali. Inoltre, il DDL stabilisce un limite oggettivo alle attività dei soci non professionisti, essi potranno partecipare solo per apporti tecnici o finanziari, ma non potranno ricevere prestazioni legali o amministrative dalla stessa società.
È introdotto un divieto espresso di svolgere attività professionali a favore del socio non professionista o di soggetti collegati, misura pensata per evitare conflitti d’interesse e commistioni tra attività forense e impresa commerciale.
leggi anche
Quanto costa diventare avvocato in Italia?

Contratti di rete nel forense: quando ammessi e con quali vincoli
La riforma valorizza il lavoro di squadra negli studi legali introducendo la “rete tra avvocati”.
Per costituirla servono almeno due professionisti iscritti all’albo, che si uniscono con un contratto di rete professionale per condividere risorse, clienti o servizi. Le reti dovranno essere comunicate al Consiglio dell’Ordine e annotate in una sezione speciale, con obbligo di trasparenza su denominazione, componenti e oggetto dell’attività.
È esclusa ogni forma di partecipazione di soggetti non iscritti: solo avvocati possono far parte della rete, anche se restano liberi di aderire a più strutture. L’obiettivo dichiarato dal Ministero è favorire la collaborazione e la specializzazione senza creare soggetti societari, rafforzando la competitività degli studi medio-piccoli.
Posso essere amministratore e avvocato? Quali incarichi sono compatibili?
La riforma dell’ordinamento forense 2025 introduce una revisione del regime di incompatibilità che per anni ha limitato la possibilità degli avvocati di assumere incarichi gestionali o amministrativi.
“Il DDL stabilisce una distinzione tra cariche gestionali compatibili e attività imprenditoriali vietate.”
Resta ferma l’incompatibilità assoluta con l’esercizio diretto e continuativo del commercio, con l’attività di intermediazione e con ogni forma di lavoro subordinato privato. Tuttavia, viene riconosciuta la compatibilità con alcune funzioni di amministrazione o controllo se l’incarico non snatura la natura professionale del soggetto e non lo pone in posizione di dipendenza economica.
Tra le novità:
- sono ammessi gli incarichi di amministratore unico, consigliere delegato o membro del consiglio di amministrazione, purché l’avvocato non partecipi alla gestione commerciale quotidiana e mantenga la propria autonomia professionale;
- è compatibile l’incarico di amministratore di condominio, a condizione che sia limitato a pochi edifici e non assuma carattere imprenditoriale;
- viene introdotta una compatibilità specifica per l’attività di agente sportivo, riconosciuta come prestazione accessoria, se svolta nel rispetto delle norme deontologiche e senza conflitti con la tutela legale degli atleti.
Il DDL chiarisce che le incompatibilità vanno lette in senso funzionale, ciò che rileva non è tanto la qualifica formale, quanto la natura e continuità dell’attività economica esercitata. Restano sempre compatibili, la docenza, la ricerca scientifica e la collaborazione editoriale.
Compatibilità tra avvocato e cariche societarie: dove passa il limite
La domanda più frequente tra i professionisti “posso essere CEO di una S.r.l. e restare avvocato?” trova finalmente una risposta normativa chiara. La riforma afferma che la carica di amministratore è compatibile se non si traduce in un’attività imprenditoriale diretta o in una subordinazione economica.
In altre parole, l’avvocato può sedere nel consiglio di amministrazione o assumere la direzione di una società solo se l’incarico è occasionale, professionale o fiduciario, e non è la sua principale fonte di reddito. Invece, resta vietata la gestione imprenditoriale abituale, come la partecipazione sistematica agli utili di una società commerciale o l’amministrazione di più imprese.
Ad esempio:
- un avvocato che fa parte del CdA di una start-up innovativa in cui presta consulenza legale resta pienamente compatibile;
- un avvocato che gestisce in modo stabile un gruppo immobiliare o una holding commerciale dovrà scegliere tra professione e impresa.
Avvocati pubblici: iscrizione all’albo e ambito di attività
Un capitolo a parte riguarda i legali degli enti pubblici. Il DDL chiarisce che l’avvocato dipendente di una P.A. deve essere iscritto all’albo e può esercitare solo nell’interesse esclusivo dell’ente di appartenenza. L’avvocato dell’ente non potrà tuttavia assumere incarichi esterni, neppure occasionali, né patrocinare cause in conflitto con la P.A. per cui lavora.
Per le amministrazioni locali, il nuovo testo ribadisce la necessità di strutture legali interne iscritte all’albo forense e coordinate da un dirigente avvocato, nel rispetto dell’art. 23 della l. n. 247/2012.
Quali attività restano riservate all’avvocato?
Secondo il nuovo testo, sono attività riservate all’avvocato:
“Quelle di consulenza, assistenza e rappresentanza legale che abbiano carattere continuativo, sistematico e organizzato e siano connesse alla giurisdizione o al procedimento amministrativo contenzioso.”
In altre parole, rientrano nel monopolio forense non solo la difesa in giudizio, ma anche la consulenza preventiva e la redazione di atti quando costituiscono un’estensione naturale dell’attività difensiva.
Il messaggio del legislatore è chiaro: la funzione di difesa resta personale, fiduciaria e inscindibilmente legata all’iscrizione all’albo.
leggi anche
Quanto costa diventare avvocato in Italia?

Monocommittenza e collaborazioni continuative: tutela dell’autonomia
La riforma interviene anche sul tema della monocommittenza per tutelare i giovani professionisti e i collaboratori di studio. Quando il rapporto è continuativo e sistematico, ma mantiene autonomia organizzativa e assenza di vincolo di orario o subordinazione gerarchica, viene qualificato come prestazione d’opera professionale ai sensi degli artt. 2229 ss. c.c., non come rapporto di lavoro dipendente.
Sono considerati indici di autonomia:
- libertà nella scelta dei tempi e dei mezzi di svolgimento dell’incarico;
- assenza di poteri disciplinari del dominus;
- possibilità di esercitare attività per altri committenti (se non esclusa per iscritto);
- compenso determinato a risultato o per attività.
Tale distinzione, chiarisce la relazione ministeriale, serve a proteggere l’autonomia dell’avvocato e a evitare l’uso strumentale di collaborazioni “parasubordinate” per eludere l’equo compenso o i contributi previdenziali.
Equo compenso e solidarietà nel pagamento
Il Ddl sulla riforma dell’ordinamento forense punta a rendere l’equo compenso una garanzia effettiva e non solo formale.
La novità principale è l’introduzione della responsabilità solidale nel pagamento del compenso tra committente e contraente principale. In concreto, se l’avvocato riceve l’incarico tramite una società, un intermediario o una struttura di servizi legali, potrà agire direttamente anche contro il cliente finale — cioè il soggetto che ha beneficiato della prestazione — per ottenere il pagamento dell’onorario.
Tale meccanismo estende la tutela della legge n. 49/2023 sull’equo compenso, impedendo che l’equità del compenso venga aggirata attraverso catene di sub-appalti o società interposte. L’obiettivo dichiarato è riequilibrare i rapporti contrattuali tra professionista e cliente forte (banche, assicurazioni, grandi imprese o pubbliche amministrazioni) e ridurre il contenzioso sui crediti professionali. Le clausole contrattuali che violano l’equo compenso saranno considerate parzialmente nulle e sostituite con i valori previsti dai parametri ministeriali.
Parere di congruità: diventa titolo esecutivo
Il Ddl approvato dal Consiglio dei Ministri introduce una novità attesa da anni: il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine diventa titolo esecutivo.
In pratica, l’avvocato che ottiene il parere positivo non dovrà più rivolgersi al giudice per la convalida, ma potrà avviare direttamente l’esecuzione forzata per il recupero dei compensi dovuti. Il parere, previsto dall’art. 13 della l. n. 247/2012, oggi certifica solo la correttezza della parcella rispetto ai parametri ministeriali (D.M. 55/2014). Con la riforma, assume valore esecutivo immediato, accelerando tempi e costi per la riscossione. Ad esempio, se un cliente non paga la parcella di 3.000 euro, l’avvocato potrà, dopo il parere di congruità dell’Ordine, procedere subito con pignoramento o precetto, senza decreto ingiuntivo.
Prima e dopo la riforma: cosa cambia nella pratica forense quotidiana
Prima del DDL, l’area riservata all’avvocato era definita per esclusione e affidata alla giurisprudenza e alla prassi. La riforma la positivizza, trasformandola in un elenco preciso di attività collegate alla giurisdizione e alla rappresentanza continuativa.
Allo stesso tempo, il concetto di collaborazione stabile viene “nobilitato”, non più segno di subordinazione, ma strumento di cooperazione professionale.
Per gli studi e le imprese, le novità comportano una revisione dei contratti e delle lettere di incarico, che dovranno specificare il tipo di rapporto (autonomo, d’opera o in esclusiva) e prevedere la clausola di equo compenso solidale. Invece, per gli Ordini forensi la riforma comporta un ampliamento delle funzioni di controllo, vigilanza sui contratti, verifica dell’equità dei compensi e monitoraggio delle nuove forme di esercizio della professione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA